Catalonia in Venice
Water Parliaments
Projective Ecosocial Architectures
Docks Cantieri Cucchini, Venezia
Presentazione
* “La raccolta di riflessioni sull’acqua relative al territorio catalano,
baleare e valenciano ci spinge, in quanto architetti, a immaginare
come possiamo mediare, attraverso la progettazione, nelle
situazioni presentate, per proporre futuri più equi e degni di
essere vissuti.
La mostra mira a creare una consapevolezza collettiva
sul ruolo dell’acqua come collaboratrice attiva nel plasmare
l’architettura, la politica e la tutela dell’ambiente. In sostanza,
vogliamo stimolare una riflessione sull’urgenza di adottare
approcci trasversali e orientati al futuro per la governance
dell’acqua, l’architettura, la terraformazione e la costruzione delle
città.
Ogni tipo di architettura è architettura dell’acqua. Dai
materiali che utilizziamo alle infrastrutture che costruiamo – gli
impianti fognari, i sistemi di raffreddamento dei server, perfino le
tecnologie di rendering – l’acqua è presente a ogni livello.
Per troppo tempo le infrastrutture idriche sono rimaste
lontane dalla vista, trattate come invisibili e inerti. Questo
ha scavato una separazione fra le nostre azioni e le loro
conseguenze ecologiche, come il fatto che le acque reflue
finiscano per tornare a noi sotto forma di cibo o bevande, di
residui di ciò che consideravamo ormai ‘scomparso’.
Questo progetto presenta l’architettura come uno spazio
di attivismo, di riflessione e di progettazione a più livelli: dalla
segnaletica che caratterizza i nostri spazi pubblici e costruisce il
nostro immaginario collettivo, ai nuovi tipi di arredo urbano, agli
elementi tecno-utopici che richiedono interventi su larga scala,
nonché alle strutture paesaggistiche che possono aiutarci a
comprendere meglio cosa accade davanti ai nostri occhi.”
* Eva Franch i Gilabert, Mireia Luzárraga e Alejandro Muiño
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
I. FONTANE DEI DATI
Barcellona è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e si trova
a fronteggiare minacce di siccità e stress idrico sempre più gravi. Durante i
periodi di siccità, le fontane senz’acqua e i giardini riarsi ricordano ai cittadini
la loro responsabilità individuale nella gestione sostenibile delle risorse idriche.
Tuttavia, elementi fondamentali della resilienza idrologica della città – come
le reti di solidarietà che gestiscono le acque sotterranee tra i quartieri oppure
i dispositivi per preservare la qualità dell’acqua – restano invisibili al pubblico,
impedendo una comprensione olistica della governance idrica urbana.
Per aumentare l’impegno della comunità e migliorare le strategie di gestione
dell’acqua, Barcellona ha realizzato le Fontane dei Dati, un innovativo sistema
di stazioni interattive che vanno a integrare la sua rete di 1.645 fontane di
acqua potabile e di oltre 301 fontane ornamentali. Queste nuove stazioni
scientifiche cittadine forniscono dati in tempo reale sulla qualità dell’acqua,
i livelli delle falde acquifere, il contenuto microbico e la potabilità. Dotate di
una tecnologia di sequenziamento del DNA accessibile e di sistemi di allarme
visivo che indicano lo stato di emergenza idrica, queste stazioni consentono
ai cittadini di partecipare attivamente al monitoraggio della qualità dell’acqua
urbana, riconnettendo le comunità alle loro risorse idriche e promuovendo un
futuro urbano sostenibile.
Oltre al monitoraggio ambientale, le Fontane dei Dati promuovono
l’alfabetizzazione scientifica e trasformano così le interazioni quotidiane in
opportunità per comprendere, prevedere e gestire in modo più efficace le sfide
della salute urbana.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
II. SALA DEI SEDIMENTI
Quando modifichiamo un corpo idrico, le conseguenze che inneschiamo non
investono solo l’area circostante, ma l’intero sistema idrologico, rimodellando
profondamente le dinamiche territoriali. Le dighe, quindi, non si limitano a
immagazzinare acqua per il consumo, l’irrigazione o la produzione di energia,
ma erigono anche barriere fisiche ed ecologiche, e trattengono sedimenti
essenziali per gli ecosistemi fluviali. La “cattura” di questi sedimenti che sono
vitali per la biodiversità, la qualità del suolo e la salute delle acque stravolge
processi ecologici cruciali e innesca effetti a cascata sul paesaggio.
Sala dei Sedimenti è una risposta a queste perturbazioni sistemiche. Si
tratta di una biblioteca riflessiva che incarna la passività delle amministrazioni
nei confronti delle azioni necessarie per preservare il Delta dell’Ebro. Lo spazio
comprende un’area lounge realizzata con lo stesso tipo di tubature di dragaggio
idrico utilizzate per pompare i sedimenti fuori dalle dighe in cui si accumulano.
I visitatori possono sedersi e osservare le due cisterne d’acqua sospese: una
racchiude sedimenti estratti dalla diga di Riba-roja, mentre l’altra contiene degli
invertebrati che sono alla base della catena alimentare di oltre 500 specie di
uccelli, pesci e altri animali del parco naturale. Parte integrante della mostra è
una serie di libri sulle diverse specie e sulla storia del Delta dell’Ebro, nonché
studi scientifici sulle tecniche che consentono ai sedimenti di fluire oltre le
infrastrutture esistenti. L’installazione invita inoltre i cittadini a firmare una
petizione per un’azione simbolica, nella speranza di realizzarne una concreta.
In uno scenario in cui l’innalzamento dei livelli del mare minaccia di
sommergere il Delta dell’Ebro prima del 2100, la Sala dei Sedimenti rappresenta
un grido d’allarme e una visione piena di speranza, e pone l’accento su
tecnologie innovative capaci di ripristinare i flussi ecologici e mettere un freno ai
danni causati dall’attività umana.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
III. PORTE IDRICHE
L’aumento e l’imprevedibilità dei fenomeni meteorologici estremi dovuti
al cambiamento climatico ci costringono a rivedere comportamenti sociali,
modelli architettonici e normative urbanistiche. È necessario ridefinire i concetti
tradizionali di architettura vernacolare e assimilare gli insegnamenti giunti da
aree geografiche lontane che da tempo si trovano ad affrontare gravi condizioni
ambientali. In questo contesto nasce Porte Idriche, un’installazione che vuole
essere una risposta diretta alle catastrofiche inondazioni di Valencia e alle
inadeguatezze dei modelli urbani tradizionali di fronte alla crisi climatica.
Porte Idriche sfida le norme della progettazione urbana, confrontandosi
con le realtà del cambiamento climatico dimostrate in modo incontrovertibile
dalle devastanti inondazioni di Valencia. L’installazione presenta porte di vetro
con incisi frammenti di norme edilizie e mappe di zone a rischio alluvione,
evidenzia la vulnerabilità finora sottovalutata delle attuali norme di sicurezza
e offre informazioni su come partecipare ai “Comités Locals d’Emergència
i Recostrucció” istituiti dalle comunità locali per procedere alle opere di
ricostruzione. Le porte presentano tipologie di cerniere diverse: una si può
aprire solo verso l’esterno, in conformità con le attuali normative di sicurezza
spagnole, mentre un’altra ha cerniere bidirezionali, a simboleggiare l’adattabilità
e il dialogo. L’installazione vuole essere una riflessione sulle recenti inondazioni,
durante le quali le porte che si aprivano solo verso l’esterno, in teoria sicure, si
sono rivelate vere e proprie trappole mortali.
Porte Idriche invita a riconsiderare gli attuali standard tecnici, le politiche
urbanistiche e le strategie di gestione del rischio di inondazioni, e a creare una
città più resiliente e sostenibile per fronteggiare le sfide idriche del futuro.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
IV. PYRINEUCUS-ECO-HYDRATOR
La limitata redditività economica delle foreste ha portato al loro abbandono
sia da parte dei proprietari privati che delle amministrazioni pubbliche. Negli
ultimi anni, i Pirenei hanno registrato un significativo aumento della copertura
forestale, dovuto in gran parte a questo abbandono. Un maggior numero di alberi
comporta un aumento dell’assorbimento di CO2 e della produzione di ossigeno,
ma questo nuovo scenario causa una riduzione della portata dei fiumi, mette
in pericolo alcune specie e in definitiva aumenta la vulnerabilità ai cambiamenti
climatici.
Il Pyrineucus-Eco-Hydrator, una specie fittizia e speculativa,
rappresenta una strategia di adattamento futuro al clima, che combina la
gestione attiva delle foreste, l’agroforestazione e le tecniche di ecoingegneria. Il
suo approccio mira non solo al ripristino ecologico, ma anche a una complessa
coesistenza fra tecnologia e natura, tanto agonistica quanto armoniosa.
Il Pyrineucus-Eco-Hydrator è progettato per selezionare e tagliare gli
alberi con il più elevato fabbisogno idrico, e alimenta un ecosistema robusto
mediante la ripiantumazione di specie autoctone resistenti, come la quercia, il
faggio e l’abete bianco. Promuovendo la biodiversità e riducendo la domanda
di acqua, il Pyrineucus-Eco-Hydrator ci ricorda l’importanza di una silvicoltura
sostenibile, a partire dai Pirenei. Utilizzando la tecnologia del “cloud-milking”,
cattura l’umidità eterea della nebbia per nutrire le giovani piante e garantirne la
crescita sana senza prosciugare fiumi e ruscelli. Nell’ambito del PEH sono state
attentamente pianificate aree protette per la fauna selvatica, che accolgono
specie chiave come il lupo iberico reintegrandole nel ricco ecosistema forestale.
Inoltre, sotto la sua egida stanno tornando le pratiche di pascolo controllato,
che contribuiscono a mantenere gli habitat aperti, a ridurre il rischio di incendi e
a favorire una ricca biodiversità.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou V. DENOMINAZIONE DI DESTINAZIONE
L’acqua piovana che irriga le terre in cui si coltivano le pere DOP di Lleida
percorre 20.000 chilometri per giungere sugli scaffali di un supermercato in
Nuova Zelanda, dove viene consumata. Tutte le risorse estratte in un territorio
finiscono per essere utilizzate altrove. L’estrattivismo agroalimentare da parte
delle grandi multinazionali è una delle cause odierne di squilibrio territoriale.
Denominazione di Destinazione presenta cinque bandiere che mostrano
cinque diverse scale e distanze della distribuzione globale: quella di 500 chilometri
indica i tragitti locali; quella di 1.000 km i paesaggi regionali; quella di 5.000 km
le esportazioni continentali; quella di 10.000 km le principali rotte commerciali;
quella di 20.000 chilometri le zone più remote del pianeta. Attraverso queste
bandiere simboliche, l’opera rivela poeticamente il viaggio invisibile intrapreso da
ogni goccia d’acqua, nutriente e raggio di sole dai fertili campi di Lleida, e i fili
nascosti che uniscono l’agricoltura locale a quella del resto del mondo.
La struttura che espone le bandiere è realizzata interamente con un unico
tubo per l’irrigazione, materiale d’uso quotidiano essenziale nelle attività agricole
della regione di Lleida. Questa scelta incarna la profonda interconnessione tra
i campi e le fonti d’acqua. Le bandiere invitano i visitatori a pensare ai viaggi
silenziosi e globali che si celano nei prodotti locali e a riflettere sulla nostra
responsabilità collettiva nel proteggere e sostenere le risorse che nutrono sia la
comunità che la terra.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou VI. COMUNITÀ DI FALDE ACQUIFERE
L’iniziativa Comunità di Falde Acquifere rappresenta una risposta provocatoria
alla crisi delle falde acquifere nelle Isole Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza e
Formentera). Sotto ogni struttura, dalle piscine degli hotel alle abitazioni
private, si estende una rete complessa e sempre più vulnerabile di falde
acquifere, soggetta alla pressione di decenni di attività estrattive dovute al
turismo e all’agricoltura industriale. Delle targhe di ceramica collocate in punti
ben visibili di case, camere d’albergo e spazi pubblici, riportano ogni luogo e
la sua falda acquifera corrispondente. Queste targhe fungono da indicatori,
mostrando le connessioni, che altrimenti passerebbero inosservate, tra l’uso
individuale dell’acqua e la vita sotterranea collettiva.
Storicamente, l’equilibrio delle falde acquifere delle isole veniva
attentamente salvaguardato attraverso tecniche tradizionali locali, come pozzi
e mulini a vento. Tuttavia, l’esplosione del turismo e le moderne pratiche
agricole a partire dagli anni Sessanta hanno gravemente danneggiato le acque
sotterranee, causando una drastica riduzione delle falde freatiche e la loro
contaminazione da acqua salata e nitrati. Attualmente, più della metà di queste
vitali comunità sotterranee sono giunte a uno stato critico che richiede soluzioni
di desalinizzazione ad alta intensità energetica.
Comunità di Falde Acquifere riunisce residenti, visitatori, ecosistemi e
responsabili politici in uno sforzo comune per ripensare e rimodellare il rapporto
con l’acqua. Non si limita solo a sensibilizzare, ma promuove un impegno politico
attivo volto alla tutela di queste riserve sotterranee. Di fronte alle conseguenze
sempre più gravi del cambiamento climatico, l’iniziativa propone un’etica
dell’attenzione, della vulnerabilità condivisa e dell’azione collettiva e ridefinisce
la nostra esistenza comune con l’acqua, creando nuove solidarietà ecologiche e
nuovi modi per le isole di coabitare con le loro comunità di acque sotterranee.
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou VII. ACQUE DEL MONDO
L’installazione Acque del Mondo, che fa parte dell’iniziativa Atlante di
Architetture dell’Acqua accessibile dalla piattaforma www.waterparliaments.org,
presenta nove straordinari casi di studio che evidenziano le interconnessioni
spesso invisibili tra architettura, acqua e giustizia ecologica. Attraverso media
interattivi e azioni su piccola scala, ogni caso di studio illustra problematiche
idriche critiche, anche se immateriali, che spesso passano sotto silenzio nel
discorso architettonico tradizionale: il suono, l’odore e altre dimensioni sensoriali.
Acque del Mondo sfida gli approcci dominanti ed estrattivi della gestione
dell’acqua e dell’architettura, sostenendo una prospettiva ecosociale. Ciascuna
delle azioni presentate cerca di conciliare il sapere locale con la responsabilità
globale e promuove architetture trasformative che affrontano le complesse
sfide legate all’acqua.
In definitiva, Acque del Mondo mira a creare una rete globale di parlamenti
dell’acqua, spazi inclusivi dedicati alla consapevolezza, al dialogo e all’azione
ecologici. Queste assemblee collaborative aspirano a fornire alle comunità di tutto
il mondo gli strumenti per rivendicare la governance dell’acqua e garantire un futuro
equo ed ecologicamente consapevole in cui l’architettura rispetti e onori i sistemi
idrici da cui intrinsecamente dipende.
Curatori: Eva Franchi Gilabert, Mireia Luzárraga e Alejandro Muiño.

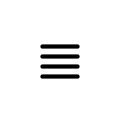

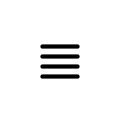
 Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou  Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou
Water Parliaments, Catalonia in Venice, Biennale Architettura 2025, Photo Flavio Coddou